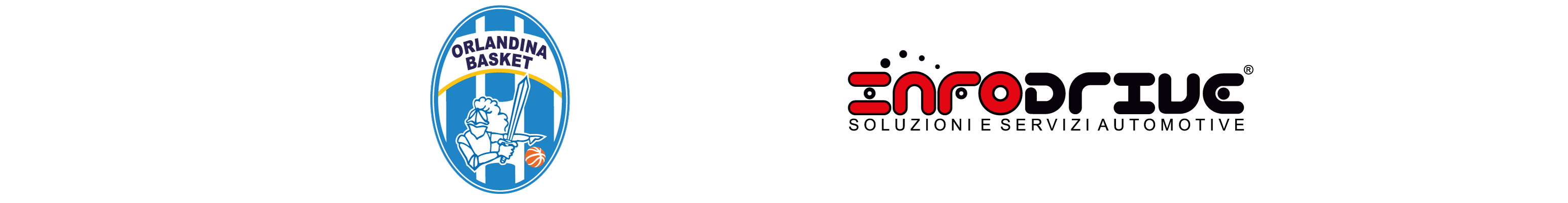La ricetta del cuoco, Di Carlo ha salvato Capo d'Orlando
 Il 42enne tecnico, il più giovane del campionato, appassionato di cucina e Formula 1, ha sollevato i siciliani dal baratro: «Grazie all’aiuto dei veterani»
Il 42enne tecnico, il più giovane del campionato, appassionato di cucina e Formula 1, ha sollevato i siciliani dal baratro: «Grazie all’aiuto dei veterani»
Massimo Oriani – Gazzetta dello Sport
Largo ai giovani. Le panchine della Serie A vanno via via sempre più svecchiandosi. Capo d’Orlando ha confermato con un biennale Gennaro Di Carlo, coi suoi 42 anni il più «acerbo» del campionato, ma anche l’artefice della salvezza dei siciliani dopo l’inizio in salita (4 vinte-10 perse) con Griccioli alla guida (ma non era tutta colpa sua), grazie a 7 vittorie in 14 gare. Di Carlo, non ce ne voglia, ma la conoscono in pochi. Si racconti.
«La mia passione per il basket nasce sin da bambino, quando avevo 8-9 anni. Ero cicciottello ma volevo fare sport e vivendo a Caserta non potevo che finire nell’orbita della Juve. Facevo il play ma non ero bravo, all’epoca ci si parametrava su Nando Gentile ed Enzino Esposito. Dopo la trafila di minibasket e giovanili, ho deciso che la strada giusta era quella della panchina. Da allora ho fatto tante esperienze, tutte straordinarie: dalla femminile con le Pantere Caserta nel ’97-98, alla Serie B con Rende. Esperienze che hanno pagato».
In che modo?
«Ho sfruttato le occasioni di arricchimento. Oggi ho la fortuna di allenare in A e non dico che la vivo come un bimbo, ma di certo con l’entusiasmo di chi sta facendo di tutto per restarci».
Cosa che si è realizzata vista il biennale firmato mercoledì.
«E’ splendido avere sicurezze, poter guardare avanti. Quando mi è stata offerta la possibilità non ci ho pensato su due volte. Con il presidente Sindoni ci siamo accordati in tre minuti. Lavoro in un sistema dove c’è sostanza dietro a giocatori, allo staff, alla dirigenza. In un club che è arrivato in alto vincendo campionati, con una competenza assoluta».
Cosa appassiona Di Carlo oltre alla palla a spicchi?
«A livello sportivo la Formula Uno. Un lontano parente per parte di mamma, di origini siciliane, gareggiava, ha anche corso una Targa Florio. Forse ha lasciato traccia nel mio Dna. Da bambino vedevo le gare in tv, mi ha sempre affascinato l’aspetto tecnologico. Mi piacciono molto le auto sportive. E ovviamente non posso che tifare Ferrari. Ma apprezzo anche molto l’organizzazione, che cerco di applicare nel mio lavoro».
Organizzazione che nel nostro basket è però lontana anni luce.
«Eppure potremmo essere così anche noi. Bisogna credere che si può far meglio, a tutti i livelli. Dobbiamo sognare ma essere anche artefici dei nostri sogni».
Altre passioni?
«La cucina. Sono goloso ma mi piace anche darmi da fare ai fornelli. Da esonerato in passato ho scoperto l’arte del cucinare. E’ l’unica cosa che mi distrae dalla pallacanestro. Serve concentrazione. Poi vivendo da solo forzatamente ho dovuto imparare. I piatti forti? Alcuni risotti, anche se non sono del Nord. E poi secondi di carne, soprattutto lo spezzatino».
Nel suo passato c’è anche Maddaloni, patria dei Gentile.
«Ho allenato Stefano nelle giovanili quando Nando invece allenava Alessandro. Con me è arrivata la sua prima convocazione per le giovanili azzurre, una soddisfazione. Assieme a Nando ho poi gestito il settore giovanile. D’estate passavamo la scopa per pulire i pavimenti in palestra. Quando ci siamo ritrovati in spogliatoio a Roma, dopo una vittoria in Eurolega sul Tau Vitoria di Ivanovic, lui da head coach e io da suo vice, ci siamo guardati in faccia e ci è scappata una lacrimuccia ripensando a quei giorni».
Come ha salvata l’Orlandina?
«Con giocatori speciali come Basile, Nicevic, Jasaitis e Ilievski, il massimo per un coach esordiente. Hanno un’etica del lavoro e una morale fuori dal comune, hanno veicolato in spogliatoio un messaggio positivo e per me sono fonte di confronto continuo. Poi una proprietà che ci ha creduto e un popolo che trasmette entusiasmo. Ah, non dimentichiamoci di un certo Boatright, un fenomeno».